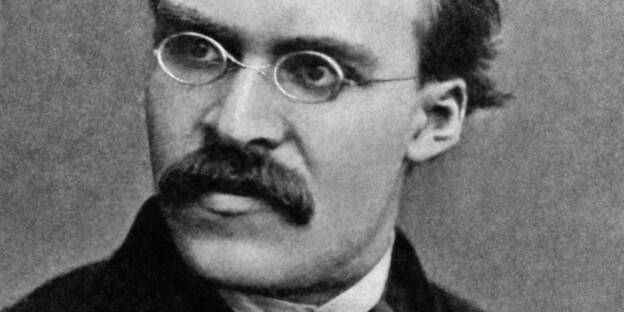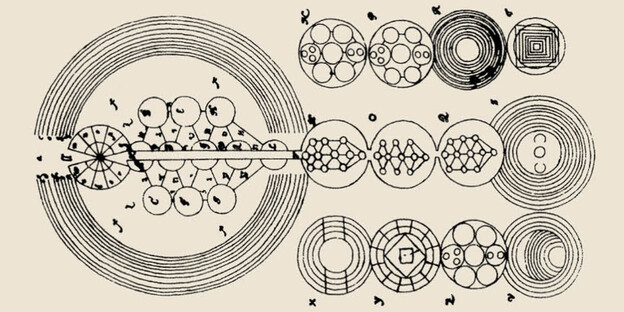Nel settembre del 1943 Dante Isella, poco più che ventenne, attraversa fortunosamente il confine italo-svizzero, e nel gennaio dell’anno successivo approda a Friburgo, dove già è insediata una piccola comunità di esuli, oltre che dall’Italia della disfatta, dalla Francia di Pétain e dalla Spagna di Franco. Al suo bisogno di «verità minime, ma certe», di maestri capaci di iniziarlo a «idee e strumenti con i quali riprendere da capo una storia tragicamente deragliata sui binari dell’inganno e dell’odio» risponde come per miracolo l’incontro, nelle aule universitarie, con un giovane filologo romanzo. È un’improvvisa rivelazione, e una grande frustata: con la generosità del suo temperamento mercuriale e di una cultura portata con signorile disinvoltura – in cui già fermenta la lezione della stilistica spitzeriana, dello strutturalismo saussuriano e della critica d’arte di Longhi –, Gianfranco Contini seduce i suoi allievi, li trasporta nell’atmosfera tesa, rarefatta dove si va preparando un’operazione di radicale novità: quella ricongiunzione di filologia e critica che avrebbe permesso di «riuscire postcrociani senza essere anticrociani». Nell’arco di un anno – cui in qualche modo riconducono, come a un nucleo essenziale, tutti gli scritti qui riuniti – matura una vocazione e, insieme, una linea di ricerca che, dalla metà degli anni Cinquanta, darà frutti (dagli studi su Dossi alle edizioni di Porta, Parini, Gadda, Manzoni) destinati a lasciare il segno.